Si tratta di una delle colonie di svernamento più importanti
in tutto il Nord-Est Italiano. Come riferito in tabella (tab. 1), le colonie di
Ferro di cavallo maggiore con più di 100 esemplari in tutto il Veneto sono
solamente 4, ovvero la colonia di transizione a Vittorio Veneto, la colonia
invernale alla cava Carli, la colonia invernale alla Voragine Casarotto e la
colonia di ibernazione del Buso della Rana.
Inoltre essa è la colonia conosciuta da più tempo, essendo
nota da oltre 50 anni. I primi dati sulla presenza di pipistrelli all’interno
di questa grande cavità carsica risalgono al 1952 (Ruffo, 1960): il 27 dicembre
di quell’anno si contarono circa 60 pipistrelli ibernanti nel Ramo del
Labirinto. La specie osservata era il Rhinolophus
ferrumequinum (Schreber, 1774). I dati successivi risalgono al 1977
(Vernier, 1978), quando il 27 marzo furono trovati 16 Rinolofi in uno dei rami
alti del Labirinto. Il numero così esiguo probabilmente si deve al fatto che il
controllo è avvenuto verso la fine del periodo di ibernazione quando la maggior
parte della colonia si era già trasferita in altri siti. Una serie di controlli
regolari sull’andamento della colonia è citata in Vernier (2000d); la
consistenza numerica valutata nell’inverno 1989/1990 era di 201 esemplari.
Negli anni successivi il numero di componenti della colonia tende a diminuire:
188 individui nell’inverno 1992/1993 e 167 nell’inverno 1993/1994. A questi
dati si aggiungono i conteggi degli inverni 1990/1991 e 2000/2001, ricavati da
fotografie scattate alla colonia in quegli anni. Nella stagione 1990/1991 sono
stati contati 157 esemplari, divisi in 2 gruppi di 102 e 55 individui. Nella
fotografia della stagione 2000/2001 si ha una visione parziale della colonia,
in cui si contano 70 esemplari, ma non si conosce il numero totale degli
individui per quell’anno.
Provincia
|
Comune
|
Sito
|
NM
|
Ci
|
Ce
|
cR
|
Padova
|
Rovolon
|
gr.Busa dell’Orso
|
7
|
I
|
|
|
Padova
|
Teolo
|
cavità artif.su
M.te d.Are
|
5
|
I
|
E
|
|
Padova
|
Teolo
|
casale abbandonato
|
4
|
|
E
|
|
Padova
|
Padova
|
sotterranei delle
Mura (Bast.I.)
|
1
|
I
|
|
|
Padova
|
Padova
|
sotterranei delle
Mura (S.Croce)
|
3
|
I
|
E
|
|
Padova
|
Padova
|
sotterranei delle
Mura (Bast.H.)
|
15
|
|
E
|
R
|
Padova
|
Padova
|
soffitte Abbazia di
S.Giustina
|
10
|
|
E
|
|
Venezia
|
Mirano
|
grotte del
Castelletto
|
12
|
I
|
E
|
|
Venezia
|
Venezia
|
Forte Carpenedo
|
1
|
I
|
|
|
Belluno
|
Vas
|
gr.d.Boranga
|
1
|
I
|
|
|
Treviso
|
Vittorio Veneto
|
ex Cava Italcementi
|
250
|
I
|
|
|
Treviso
|
Pederobba
|
gr.Bislonga
|
10
|
|
E
|
|
Treviso
|
Pederobba
|
tunnel artificiali
(bellici)
|
5
|
I
|
|
|
Treviso
|
Susegana
|
gr.artificiali del
Castello
|
1
|
I
|
|
|
Treviso
|
Susegana
|
gr.Bus de le Fade
|
2
|
I
|
|
|
Treviso
|
Nervesa d.Battaglia
|
gr.non catastata
|
1
|
I
|
|
|
Verona
|
S.Anna d’Alfaedo
|
gr.A del Ponte di
Veja
|
4
|
I
|
|
|
Verona
|
S.Anna d’Alfaedo
|
gr.Coal di Campore
|
10
|
|
E
|
|
Verona
|
Torri del Benaco
|
gr.Tanella
|
10
|
|
E
|
|
Verona
|
Velo Veronese
|
Covoli di Velo
|
3
|
|
E
|
|
Verona
|
Brenzone
|
gr.dei Trovai 157
|
3
|
|
E
|
|
Verona
|
Tregnago
|
gr.Damati
|
15
|
|
E
|
|
Verona
|
Peri
|
gr.Spurga di Peri
|
12
|
I
|
|
|
Vicenza
|
Arcugnano
|
gr. Voragine
Casarotto
|
135
|
I
|
|
|
Vicenza
|
Longare
|
gr.della Guerra
|
10
|
I
|
E
|
|
Vicenza
|
Longare
|
gr.della Mura
|
15
|
I
|
E
|
|
Vicenza
|
Longare
|
cava Carli
|
240
|
I
|
|
|
Vicenza
|
Monte di Malo
|
gr.della Poscola
|
3
|
I
|
|
|
Vicenza
|
Monte di Malo
|
gr.Buso della Rana
|
205
|
I
|
|
|
Vicenza
|
Monte di Malo
|
gr.Buco d.Soglio
|
3
|
I
|
|
|
Vicenza
|
Monte di Malo
|
gr.Buco d.Soglio
|
1
|
I
|
|
|
Vicenza
|
Monte di Malo
|
abitazione rurale
|
35
|
|
E
|
R
|
Vicenza
|
Valstagna
|
grotte di Oliero
|
4
|
I
|
|
|
Vicenza
|
S.Pietro Valdastico
|
voragine delle
Banchette
|
4
|
I
|
|
|
Tab.
1 – Lista aggiornata delle colonie di Rinolofo maggiore segnalate per la
regione Veneto (da Vernier, 2004; modificato). Abbreviazioni: NM= numero
massimo di individui osservati in un singolo sito; Ci= colonia invernale; Ce=
colonia estiva; cR= colonia riproduttiva
|
N° esemplari
|
1952/1953
|
60
|
1976/1977
|
16*
|
1989/1990
|
201
|
1990/1991
|
157
|
1992/1993
|
188
|
1993/1994
|
167
|
2000/2001
|
70*
|
2003/2004
|
146
|
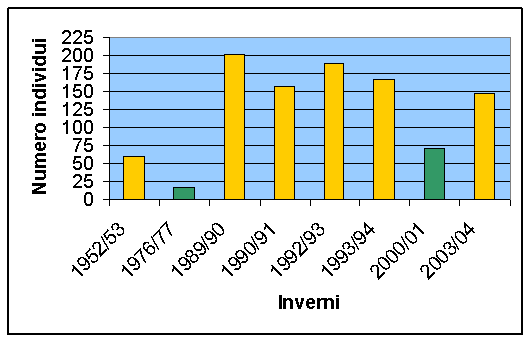 |
I dati storici servono comunque per fare alcune
considerazioni sui cambiamenti della colonia nel corso degli anni. Sono state
analizzate 9 fotografie, che ricoprono un periodo complessivo di 15 anni e si
può notare come il numero di esemplari vada da un massimo di 201 (1989-1990) ad
un minimo di 146 (2003/2004). Complessivamente il numero di esemplari negli ultimi
15 anni supera le 150 unità, valore mantenuto anche nell’inverno 2003-2004.
Quindi, anche se in 15 anni la colonia ha subito un calo non indifferente del
27%, è comunque ancora presente all’interno della grotta e ancora è fra le più
numerose del Veneto.
Se si confrontano le fotografie dell’inverno 1993-1994 (fig.
5.2) e dell’inverno 2003-2004 (fig.5.3), si possono considerare le variazioni
della colonia nell’intervallo di 10 anni. Innanzitutto si nota che il punto di
attacco della colonia all’interno della grotta è lo stesso. In entrambe le
stagioni gli animali si trovavano in una saletta di uno dei rami alti del
“Labirinto”, sulla stessa parete e a distanza di qualche metro l’una
dall’altra; nella foto del 1994 infatti la colonia è spostata 1-2 metri più in
basso rispetto al 2004. Probabilmente gli animali hanno scelto di posizionarsi
un po’ più in alto a causa del disturbo arrecato dal consistente passaggio di
speleologi e visitatori al di sotto del sito di attacco.
Il numero di individui che compongono la colonia nei due
anni differisce di una ventina di animali (167 nel 1994 e 146 nel 2004), ma si
nota come l’area occupata dalla colonia nel 2004 (fig. 5.3) sia di gran lunga
minore rispetto all’area occupata nel 1994 (fig.5.2). Nel 2004 gli animali erano
concentrati in un unico punto, a stretto contatto tra loro, mentre nel 1994 gli
individui erano più sparsi sulla parete rocciosa e mantenevano una certa
distanza tra loro.
Questo tipo di disposizione (individui sparsi e distanti tra
loro) si riscontra solo nella fotografia del 1994; infatti se si osservano le
fotografie degli anni precedenti si nota come la colonia sia formata
prevalentemente da un gruppo compatto ed omogeneo, al cui interno i pipistrelli
sono molto vicini tra loro.
Anche in queste foto, dal tipo di roccia e dalla presenza di
abbondante fango intorno alla colonia, si intuisce che il sito di attacco è lo
stesso, anche se non ci sono riferimenti del punto preciso dove si trova la
colonia. Sicuramente gli animali del secondo gruppo di febbraio 1991 e quelli
del 04-03-1993 si trovano nello stesso punto, come si può notare dal contorno
della roccia sulla destra delle fotografie.
Fig. 5.2- Fotografia della colonia scattata il 2 gennaio
1994. Nel corso della stagione invernale 1993-1994 gli individui che formavano
la colonia erano 167. (foto S. Sedran)
|
Fig. 5.3- Fotografia
della colonia scattata il 24 dicembre 2003. Nel corso della stagione invernale
2003-2004 gli individui che formavano la colonia erano 146.
|
09-06-2004
15-06-2004
21-06-2004
30-06-2004
14-07-2004
02-09-2004
La grotta Buso della Rana si apre con
una grande volta su un piazzale circondato da piante decidue ed arbusti, tipico
ambiente di caccia per i pipistrelli.
Durante il
periodo di autunno 2003 e primavera-estate 2004 sono state effettuate
osservazioni sull’attività di volo di Pipistrelli (Rinolofi e non) all’esterno
della grotta e nel primo tratto all’interno (nel grande androne di ingresso e
lungo i primi 20 metri di sviluppo del Ramo Principale), per verificare i
movimenti dei pipistrelli presenti nell’area e riconoscere eventuali altre
specie presenti nel territorio e nell’area del comune di Monte di Malo
(Vicenza).
Inoltre
dovevano essere determinate le fessure utilizzate dagli animali per entrare ed
uscire dalla grotta. Infatti l’ingresso è costituito da un’ampia volta,
profonda circa 20 metri sulla quale si aprono tre accessi principali: sulla
destra si trova il Ramo Destro dell’ingresso, un ramo che prosegue per qualche
centinaio di metri e poi si ricollega ad altri rami all’interno della grotta;
in fondo alla volta e ad un'altezza di circa 10 metri si apre una struttura
stretta e profonda che sembra chiudersi dopo alcuni metri (punto G, fig. 4.1); sulla
sinistra si sviluppa il vero e proprio ingresso, da cui si accede al Ramo
Principale e al resto della grotta.
Le
osservazioni furono condotte da mezz’ora prima del tramonto e per 90 minuti
circa, con osservazione diretta nei mesi di settembre 2003, aprile e giugno
2004, e con l’utilizzo di un rilevatore di ultrasuoni (bat-detector) nei mesi
di giugno, luglio e settembre 2004.
I bat-detector sono apparecchiature che
rendono udibili i segnali di ecolocazione dei pipistrelli, permettendo al
ricercatore di riconoscere la specie sul campo senza dover necessariamente
catturare l’animale. Le emissioni ultrasoniche dei pipistrelli comprendono sia
segnali sociali che impulsi di ecolocazione. Tutte le specie europee di
pipistrelli emettono impulsi di ecolocazione, poichè essi producono rapidi burst sonori, o impulsi, e ricevono gli echi degli ostacoli e delle prede.
Come riferito ampiamente in bibliografia, ogni specie di pipistrelli utilizza
delle specifiche strutture morfologiche tempo-frequenziali, così da poter
essere caratterizzata da un unico modello di ecolocazione (Ferrero et al., 1995).
Durante il controllo dell’11 Settembre
2003 sono stati osservati animali in volo che sembravano appartenere a due
specie diverse. I pipistrelli appartenenti alla prima specie erano di
dimensioni maggiori ed uscivano con volo rettilineo dal Ramo Principale o dal
Ramo Destro; quelli della seconda specie erano più piccoli e sembravano uscire
da fessure sulla parete rocciosa sopra l’ingresso della grotta. Questi ultimi
appena usciti volavano in cerchio in prossimità della parete e poi se ne
andavano. Il tempo di uscita e di volo di caccia all’esterno della grotta è
continuato per un’ora e dieci minuti.
Le osservazioni con l’utilizzo del
rilevatore di ultrasuoni (bat-detector) sono iniziate in data 21 giugno 2004.
Utilizzando una frequenza di ascolto di circa 35 kHz si sono potuti distinguere
chiaramente gli ultrasuoni della specie Hypsugo
savii, o Pipistrello di Savi, un Vespertilionide di piccole dimensioni
abbastanza comune in Italia.
In data 2 settembre 2004 sono stati
trovati in grotta, nel corridoio del primo tratto, 3 esemplari appesi in
fessura, 2 Rinolofidi e un Vespertilionide che emetteva un acuto stridìo al
passaggio di un operatore. Essendo stata l’ora prossima al tramonto, dopo pochi
minuti furono rilevati in volo dei Rinolofi maggiori; una buona frequenza
d’ascolto era situata a 85 kHz, ma il vespertilionide non fu riconosciuto. Più
tardi esemplari di Ferro di cavallo maggiore sono stati rilevati in volo di
caccia a breve distanza dall’ingresso della grotta.
Gli esemplari in volo, rilevati con il
bat-detector nel loro volo di caccia nell’area del piazzale antistante
l’ingresso della grotta, volavano ad altezze di 5-10 metri dal suolo con una
frequenza di 36-38 kHz (Hypsugo savii)
cacciando a volo libero, con traiettorie circolari o ellittiche; il loro volo
di caccia è durato circa 45-50 minuti. Qualche metro più in alto sono stati
visti e rilevati due esemplari di Serotino comune, Eptesicus serotinus, specie ampiamente diffusa in Nord Italia e nel
Veneto (Vernier, 1996a).
Tra gli esemplari registrati in uscita
dalla grotta, pochi passaggi a circa 65 kHz possono essere riferiti a un
esemplare di Miniottero (Miniopterus
schreibersii), specie ritrovata e fotografata all’interno della grotta a
circa 10 metri dall’ingresso in data 05/03/2004 (fig. 5.13).
Quindi gli esemplari
che si rifugiano nella grotta Buso della Rana appartenenti a diverse specie
cacciano tutti, almeno per una parte della notte, a brevissima distanza dalla
grotta stessa, direttamente sulla e nella vegetazione arbustiva e arborea che
circonda l’area del piazzale antistante l’ingresso della grotta, e questo
rappresenta un indubbio vantaggio per gli animali che si possono nutrire appena
usciti e con un dispendio minimo di energia.

Nel
primo periodo di ibernazione, ovvero da dicembre 2003 a inizio gennaio 2004, la
temperatura della grotta era di 8-9°C (tab. 4): si registravano spostamenti
degli animali all’interno della grotta e si trovavano pipistrelli isolati
lontani dal gruppo che formava la colonia. Secondo Ransome ed Hutson (2000),
durante questo periodo e a queste temperature gli animali si risvegliano ogni
1-2 giorni e sono sensibili a disturbi dall’esterno (luce, passaggio di
persone, rumore). Infatti, durante i controlli di questo periodo si osservavano
movimenti oscillatori degli individui della colonia ed alcuni di essi
prendevano il volo quando venivano illuminati.
Ad
inverno inoltrato (fine gennaio, febbraio, metà marzo 2004) la temperatura
registrata all’interno della grotta era 6-7°C (tab.4) e gli animali stavano
maggiormente a contatto tra loro; anche gli individui che prima erano isolati
in questi mesi si sono uniti al gruppo principale della colonia. Per gli Autori
inglesi (Ransome e Hutson, 2000; Ransome, 1971) i risvegli in questo periodo
avvengono ogni 8-12 giorni e si abbassa la sensibilità alla luce e ai disturbi
provocati dall’esterno. Infatti, durante i controlli di questo periodo gli
animali apparivano in profondo stato di torpore e rimanevano praticamente
immobili quando illuminati.
Alla
fine del periodo invernale (fine marzo 2004) la temperatura all’interno della
grotta è tornata ad essere di 8-9 °C (tab.4) e in data 31 marzo 2004 la colonia
non era più presente nel sito di attacco. Secondo diversi autori (Ransome,
1968; 1971; 1980; Ransome e Hutson, 2000; Gaisler 2001) la fine del letargo può
avvenire tra febbraio e maggio nel Regno Unito e nell’ultimo periodo i
pipistrelli si svegliano sempre più frequentemente. Di fatto i componenti della
colonia in esame in due settimane si sono tutti risvegliati definitivamente ed
hanno abbandonato il loro rifugio invernale per spostarsi verso i rifugi di
primavera-estate.
Durante
il periodo di ibernazione la colonia era posizionata in un ramo fossile
chiamato “Labirinto”, a circa 500 metri dall’ingresso. I Rinolofi erano appesi
su una parete quasi verticale, in una posizione strategica difficilmente
raggiungibile. La colonia era suddivisa in due gruppi principali, distanti tra
loro qualche decina di centimetri probabilmente a causa di un tratto irregolare
di roccia. Il numero totale di individui nel corso della stagione è stato in
media 142, con un massimo di 146 registrato il 14 febbraio 2004 ed un minimo di
118 registrato il 24 dicembre 2003.
La
colonia all’interno del Buso della Rana è una delle colonie di ibernazione più
importanti e numerose (con oltre 100 individui) del nord-est italiano (Vernier,
1990a). Inoltre essa è la colonia nota da più tempo, osservata già nel 1952
(Ruffo, 1960).
La
specie che la compone, il Ferro di cavallo maggiore, è considerata a rischio in
tutta Europa ed è inserita tra le specie di interesse comunitario dalla
Direttiva Habitat del 1992. Si tratta infatti di una specie molto vulnerabile,
che risente pesantemente dell’inquinamento del suo ambiente di caccia. Inoltre
essa è fortemente danneggiata dall’uso massiccio di pesticidi in agricoltura,
che da una parte causano una forte diminuzione di insetti, sua unica fonte
alimentaria, dall’altra contribuiscono ad un accumulo di sostanze tossiche
nell’organismo, con effetti anche mortali. Molto spesso gli effetti nocivi
causati dai pesticidi si riscontrano durante il periodo di ibernazione, nel
corso del quale gli individui muoiono per la presenza di sostanze tossiche
assimilate precedentemente (Stebbings, 1988). Anche l’alterazione e la
distruzione dei siti di rifugio contribuiscono al declino di questa specie.
Essa necessita di siti di rifugio sicuri e confortevoli per la riproduzione e
per lo svernamento e sempre più spesso edifici e vecchi palazzi, che prima
offrivano i requisiti necessari, vengono demoliti o ristrutturati, comportando
la diminuzione del numero di rifugi prima frequentati.
Le
grotte, che costituiscono il rifugio invernale preferito da questa specie, sono
spesso frequentate da un gran numero di speleologi, escursionisti o curiosi,
che inevitabilmente disturbano le colonie in ibernazione. E’ questo il caso del
Buso della Rana, grande cavità carsica che per la sua fama e l’accesso
relativamente agevole, è frequentata durante tutto l’anno da gruppi numerosi di
speleologi ed escursionisti.
Se
si considerano i dati sul numero di componenti della colonia negli anni passati
(tab. 1 e fig. 5.1), si osserva un calo del 27% negli ultimi 15 anni e del 13%
negli ultimi 10. Questa diminuzione è indubbiamente significativa, ma tende a
stabilizzarsi e può essere interpretata anche come un’oscillazione naturale
della colonia. Comunque la colonia supera abbondantemente i 100 esemplari e
rimane ancora tra le più numerose del nord-est italiano.
Osservando
le fotografie degli anni passati si nota come la colonia si posizioni sempre
nello stesso sito all’interno della grotta, ovvero in una saletta del Labirinto
(punto A; fig. 4.1) che comunica con il Ramo del Pantano, cercando di
collocarsi in punti inaccessibili per i visitatori.
Nel
corso della stagione 2003/2004 non sono stati trovati esemplari morti
all’interno della grotta ed il numero di individui conteggiati non ha subito
cali dall’inizio alla fine dell’inverno: ciò indica che durante il letargo non
si sono verificati decessi tra i componenti della colonia a causa di un
accumulo di sostanze tossiche e che quindi l’ambiente circostante non è
particolarmente inquinato.
Si
può quindi concludere che il Ferro di cavallo maggiore trova ancora in questa
grotta i requisiti necessari per svernare e che l’ambiente circostante non è
inquinato o alterato in modo determinante per questa specie. Il disturbo
causato dal traffico di persone all’interno della grotta infastidisce senza
dubbio gli animali, che però cercano di attenuare il disagio spostandosi un po’
più in alto in punti difficilmente accessibili da gruppi di persone. Ci sono
buone speranze che questi pipistrelli continuino a scegliere questa grotta come
sito di
ibernazione e che la colonia sia
presente ancora per molti anni al suo interno.