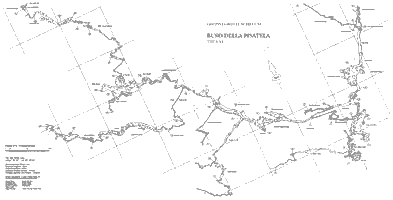
Scarica il rilievo in pianta del 2007
Buso della Pisatela
Leonardo Busellato - Gruppo Grotte Schio
NUOVE STRAORDINARIE SCOPERTE SPELEOLOGICHE NEL TERRITORIO DI MONTE DI MALO
tratto da "Acqua e Terra della Valleogra"-Sentieri culturali 3, 2003
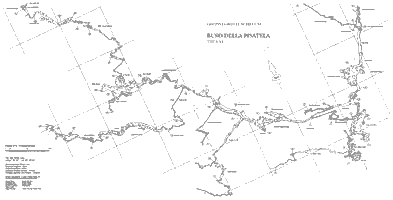
Scarica il rilievo in pianta del 2007
1. Premessa. L'altopiano del Faedo.
Il nome Monte di Malo, nell'ambiente speleologico, viene immediatamente associato
a quello di Buso della Rana, una delle grotte più lunghe d'Italia, nota
agli studiosi e a tutti gli appassionati che frequentano gli ambienti naturali
ipogei e "madre" di tutti gli speleologi veneti i quali, quasi con
affetto la chiamano "la Rana" senza bisogno di altri aggiuntivi.
La grotta è cara anche a tutti coloro che sanno apprezzare i fenomeni
naturali non ancora manomessi dall'uomo e a quanti vogliono vivere l'avventura,
anche di un solo giorno, nelle viscere della terra; migliaia sono infatti,
ogni anno, le persone che vengono accompagnate a visitare la grotta da tutti
i gruppi speleologici veneti e da quelli attivi nelle regioni contigue. Un
sapiente ricupero dell'ambiente esterno attuato dall'Amministrazione Comunale
di Monte di Malo, sostenuto anche dalla Provincia di Vicenza, sottolinea l'importanza
del sito ed ha contribuito a farlo inserire tra i Siti di Interesse Comunitario
(SIC) con il vantaggio importante di veder facilitati gli interventi di protezione
e di tutela dell'ambiente.
La descrizione delle esplorazioni e degli studi eseguiti in questa grotta ha
fatto scorrere fiumi di inchiostro ma forse la trattazione più importante è stata
redatta da un gruppo di studiosi e specialisti appartenenti a gruppi veneti
e trentini ed è stata pubblicata nel 1960, in monografia, da «Rassegna
Speleologica Italiana», la più prestigiosa rivista speleologica
di quegli anni. Artefici dello studio furono Aldo Allegranzi, Giorgio Bartolomei,
Alberto Broglio e Alberto Rigobello del Gruppo Grotte "G.Trevisiol" C.A.I.
di Vicenza, Angelo Pasa, Sandro Ruffo, e Francesco Zorzi del Museo di Storia
Naturale di Verona, Cesare Conci, Antonio Galvagni e Luciano Tamanini studiosi
trentini, con il supporto anche di alcuni elementi del Gruppo Grotte del C.A.I.
di Schio tra i quali ricordiamo Giovanni (Giannino) Giacobbi.
La risonanza suscitata dagli scritti sul grandioso fenomeno carsico fece conoscere
il paese di Monte di Malo e l'altopiano del Faedo in tutta l'Europa speleologica
e in particolare nel mondo scientifico dedito allo studio del carsismo e della
chimica dei carbonati.
L'altopiano del Faedo, rispetto ai grandi altopiani carsici, è veramente
minuscolo ma grazie alla sua particolare natura geologica e alla favorevole
successione stratigrafica ha permesso la formazione di cavità di dimensioni
straordinarie. Nell'area nord occidentale l'andamento dei reticoli idrici sotterranei è condizionato
dalla presenza di una estesa colata di basalti olivinici e vulcaniti, sormontata
da una pila di calcari oligocenici (calcareniti di Castelgomberto). I basalti,
grazie alla loro impermeabilità e alla loro giacitura, hanno determinato
lo scorrimento incanalato delle acque da Ovest verso Est secondo la generale
immersione degli strati. Una leggera flessura del letto impermeabile e una
serie di fratture della massa sedimentaria sovrastante hanno condizionato lo
sbocco delle acque, soggette a grandi pressioni idrostatiche, in corrispondenza
dell'attuale ingresso del Buso della Rana. Nel tratto sud orientale dell'altopiano,
in prossimità dell'abitato di Priabona, lo scorrimento idrico non può raggiungere
il livello di base grazie alla presenza di potenti ed estesi orizzonti marnosi
piuttosto impermeabili (marne del Priaboniano) nei quali lo scorrimento i-drico
principale avviene ancora oggi in regime freatico lungo sistemi di condotte
vascolari. A Priabona, infatti, troviamo un'altra grande grotta, la Grotta
della Poscola, esplorata da elementi del Gruppo Grotte "Trevisiol" di
Vicenza che hanno saputo operare in ambienti veramente ostili, superando grandissime
difficoltà e con l'applicazione anche dì tecniche subacquee.
Sugli stessi livelli ma sul versante di Cereda sono presenti altre grotte con
corsi d'acqua minori e precisamente la Grotta del Cameron e il Buso dell'Acqua.
Un capitolo a sé è rappresentato dalla Grotta ai Cocchi in località Spagnago,
una grande grotta ricca di drappeggi concrezionali, esplorata dal Club Speleologico "Proteo",
che si sviluppa in calcari eocenici al di sotto del livello impermeabile sul
quale si estende il Buso della Rana e la Grotta della Poscola.
La sommità dell'altopiano del Faedo è segnata da diffusissime
manifestazioni di carsismo superficiale che si presenta con estese concentrazioni
di campi solcati a carso parzialmente coperto e da innumerevoli doline di ogni
forma e dimensione che movimentano tutto il paesaggio. L'unità morfologica
dell'altopiano è segnata profondamente a SE dalla Valle Faeda e a NW
dalla Valle delle Lòre il cui andamento segue i principali motivi tettonici
della nostra zona.
Il nome di Valle delle Lòre (grandi imbuti per il travaso del vino nelle
botti) è particolarmente significativo perché è legato
alla presenza di tutta una serie di doline a gradinata che, assorbendo le acque
meteoriche, hanno reso fossile la valle.
Le calcareniti di Castelgomberto, interessate da una diffusa permeabilità accidentale
dovuta ad un'intensa fratturazione, hanno un alto contenuto di materiale insolubile
il quale, quando la roccia subisce l'azione aggressiva dell'acqua piovana acida
in anidride carbonica, tende a depositarsi e ad occupare il fondo delle doline
impermeabilizzandolo tanto da consentire, secondo un testimone oculare del
luogo, la formazione in almeno una di queste depressioni di un laghetto temporaneo
(testata della Valle delle Lòre, al limitare del bosco dei Maistri)
come nei polje del Carso croato e sloveno.
In tutto l'altopiano del Faedo, attualmente, sono note un centinaio di cavità per
lo più ad andamento verticale. Tra le grotte verticali possiamo ricordare
grotte ormai storiche come la Spurga dei Forni, la Spurga del Barbeta e la
bellissima Spurga delle Parpanoie, esplorate negli anni '60 dal Gruppo Grotte
Schio C.A.I., ma i primi veri abissi, per profondità e per complessità,
entrati nel novero dei grandi abissi del Veneto, sono la Spurga del Viperotto,
il Buso de Checo e l'Abisso Papanero esplorati dal Gruppo Speleologi Malo.
Questi abissi avevano acceso la speranza di raggiungere il livello della falda
sospesa prossima ai basalti e di penetrare così in grandi gallerie appartenenti
al sistema della Poscola e del Buso della Rana. Purtroppo la presenza di diffusi
depositi di riempimento clastici e argillosi aveva impedito di realizzare tale
congiunzione.
Il Comune di Monte di Malo, nell'intento di valorizzare e far conoscere l'ambiente
naturale e i fenomeni carsici presenti sul suo altopiano, ha realizzato una
serie di itinerari didattici di straordinario interesse. Per apprezzarli appieno, è opportuno
rivolgersi agli appassionati, che seguono il Museo dei Fossili del Priaboniano
realizzato, sempre dal Comune di Monte di Malo, in località Priabona,
e in particolare al maestro Renato Gasparella che rappresenta un po' l'anima
di questo gioiello di museo.
2. Il Buso della Pisatela.
Quando si ha la fortuna di potersi immergere in un ambiente naturale straordinario
come l'altopiano del Faedo è sempre importante osservare ogni minimo
particolare: infatti, chi percorre i suoi sentieri durante la stagione invernale,
in presenza di una copertura nevosa, potrà notare con frequenza una
serie di aree sgombre dalla neve e, avvici-
nandosi, percepire una corrente d'aria calda che proviene da strettissime fessure
aperte nella roccia o attraverso cumuli di clastici che ricoprono il fondo
di piccoli avvallamenti. Se la temperatura esterna è particolarmente
rigida, sembrano materializzarsi delle figure fantasmago-riche formate da eterei
vapori che si librano nell'aria e poi scompaiono. La spiegazione di questo
fenomeno, comune negli ambienti carsici, sta nel fatto che tutte le grotte
di una certa estensione e con ingressi a quote diverse sono interessate da
abbondanti correnti d'aria che spirano in un senso o nell'altro in base alla
differenza di temperatura tra l'interno della grotta e l'esterno. La temperatura
interna delle grotte è abbastanza stabile e tende alla media stagionale
dell'area sulla quale insiste la grotta stessa. In genere, durante la stagione
invernale, l'aria interna alla grotta è più calda di quella esterna
e tende quindi a salire
attraverso fessure che comunicano con l'esterno richiamando aria fredda dall'ingresso
più basso. In questi casi siamo in presenza di una corrente entrante
come è perfettamente avvertibile al Sifone del Buso della Rana. D'estate,
l'aria interna alla grotta è più fredda e tende quindi a scendere
in basso scivolando all'esterno, lungo il versante del monte o lungo il solco
vallivo. Questo movimento richiama aria dalle fessure in alto e si innesca
quindi una corrente d'aria entrante dall'alto e la grotta "soffia" dall'ingresso
basso.
Durante una escursione estiva, sul versante di una piccola dolina imbutiforme,
con sezione trasversale a triangolo isoscele a vertice in basso, era stato
notato un buchetto di sezione ellittica, quasi coperto da una cortina di edere
pendule che si cullavano al "respiro della terra".
L'abbondante corrente d'aria che, d'estate, usciva dal cunicolo suggeriva trattarsi
di un "ingresso basso", ma "basso" rispetto a cosa, dato
che nelle immediate vicinanze c'era veramente ben poco di più alto?
Nessuno avrebbe neanche osato immaginare il mondo che stava al di là di
quel nero pertugio. Il desiderio di capire il fenomeno spinse gli speleologi
del C.A.I. di Schio a iniziare uno scavo come già gli stessi a-vevano
tentato, con scarsi risultati, in almeno altre tre fessure dell'area. Stranamente
molti continuarono nel tempo a credere in quella che era stata ottimisticamente
battezzata "Pissatela" secondo un termine dialettale locale che chiama
così il girino, o piccola rana, in omaggio al famosissimo Buso della
Rana che distende le sue spire all'interno dell'altopiano carsico del Faedo
- Casaron. E fu un'epopea di scavi che durò per oltre vent'anni e vide
avvicendarsi generazioni di speleologi scledensi senza che mai venisse meno
la speranza di entrare in un nuovo, grande, sistema carsico. Finalmente la
costanza fu premiata: infatti, dopo quasi quaranta metri di grotta semi artificiale
percorsi scavando lungo fessure angosciose, intervallate da modesti pozzetti,
all'inseguimento di un filo d'aria, finalmente ci fu la prima scoperta: quasi
settecento metri di grotta nuova con un grande salone sotterraneo e un discreto
corso d'acqua che scorre in un troncone di galleria interessato da grandi crolli.
Dalla galleria, l'acqua si immette nel salone detto dell'Orda e scompare gorgogliando
al di sotto di una gigantesca frana.
E ancora gli speleologi a non demordere di fronte a quella frana che sembrava
deridere i loro sforzi ma allo stesso tempo pareva lanciare sempre nuove esche
e nuove sfide, con neri interstizi tra i massi o con gorgoglii sommessi. Finalmente
fu scoperto il punto debole della frana e un nero vuoto sottostante riaccese
la speranza di nuove scoperte.
Dopo uno scavo ciclopico, calando in uno stretto pertugio aperto tra massi
incombenti, fu possibile raggiungere una minuscola spiaggia in riva ad un misterioso
torrente sotterraneo. Seguendo il corso d'acqua fu raggiunta la sponda di un
lago, nero, gelido, profondo, che toccava la volta di una galleria, più che
vasta, immaginata, protesa verso l'ignoto. Sulla volta, sgombro dall'acqua,
rimaneva uno strettissimo canale di dimensioni sufficienti a contenere il capo
di uno speleologo senza casco. Il gelido abbraccio dell'acqua che arrivava
a filo del mento non fermò gli esploratori i quali, seguendo sempre
il filo d'aria, riuscirono ancora una volta a superare l'ostacolo, denominato "Stargate",
porta delle stelle, e a penetrare in un nuovo complesso sotterraneo gigantesco.
A monte dello "Stargate", il Ramo "Giannino Giacobbi",
una grande galleria che rappresenta l'asse principale della grotta ed è percorsa
da un torrente che getta le sue acque nello "Stargate". La dedica
a Giannino Giacobbi rappresenta un deferente omaggio al secondo presidente
del dopo guerra che resse le sorti del gruppo con straordinario impegno specialmente
nel campo della ricerca preistorica.
Procedendo nel ramo principale si incontrano il Ramo "del Sorriso" e
la Bocca "dello Squalo", quest'ultima caratterizzata da un ricco
drappeggio di stalattiti e stalagmiti che richiamano l'immagine famosa del
film Lo squalo, e poi il Ramo "dei Centoventi" che si biforca in "Acqualandia",
nome che è tutto un programma. Più avanti si incontra il Ramo "del
Cigno" con il tratto iniziale detto "del Brutto Anatroccolo" che
poi evolve in una galleria di dimensioni eccezionali e, ancora, il Ramo "delle
Gettate" la cui sezione è tagliata a mezza altezza da una spessa
lastra concrezionale a letto pianeggiante e il "Tunnel", una galleria
dalle morfologie stupende caratterizzata nella parte alta da una condotta a
sezione ellittica che sembra scavata da mano umana mentre, nella parte bassa,
il canale di approfondimento per scorrimento a pelo libero ha inciso uno strato
interessantissimo di conglomerato composto da un insieme di clastici misti
di calcare e basalto. E poi la Cascata con un discreto salto d'acqua che si
frange con dolce sciacquio nel laghetto sottostante e più avanti il
Ramo sopra la Cascata e il "Tira Bora" il cui nome sente l'influsso
di temi internazionali contemporanei alla scoperta.
Questi nomi, divenuti familiari, rappresentano migliaia di metri di nuova grotta,
con gallerie impreziosite da straordinari drappeggi di stalattiti, percorse
da torrenti di acqua limpida, abbellite da laghetti cristallini i cui silenzi
sono rotti solamente dallo scroscio di piccole cascate.
Lo "Stargate", con il mistero di due torrenti confluenti e apparentemente
nessun emissario, sollecitò non poco la fantasia degli speleologi finché un'attenta
osservazione, aiutata anche da qualche grammo di fortuna, non consenti la scoperta
ancora di un esiguo canale scavato sulla volta di una vasta galleria sommersa
il quale rappresentò la chiave per la
scoperta dei rami a valle. Altri nomi si aggiunsero a quelli già citati:
il Ramo "Schio", il Ramo "del By-Pass", il Ramo "Carnevale",
e grandi laghi come il Lago Lungo e ancora saloni grandiosi come la Sala "delle
Mogli", ...un'epopea entusiasmante di scoperte... fino ad una frana, immobile,
ermetica, per ora irridente gli sforzi e le speranze degli speleologi. Qui
forse siamo in prossimità di una faglia che ha tagliato in due la montagna.
L'acqua se ne va attraverso un laminatoio aperto nella viva roccia, invalicabile
all'uomo. Una forte corrente d'aria spira attraverso i massi di frana... E...
a valle di tutto il sistema c'è la Rana, lontana o vicina che sia, c'è la
Rana, e prima o poi sarà fatta la congiunzione!
Monte di Malo, con il suo altopiano carsico, torna alla ribalta speleologica
nazionale, per ora, con le due grotte più lunghe del Veneto ma non è ancora
finita...
3. Considerazioni di carattere idrologico.
L'importanza di questa straordinaria scoperta, la più grande finora
dopo il Buso della Rana, consiste in una migliore e più approfondita
conoscenza del territorio ma principalmente, a nostro avviso, nella intercettazione
dei due notevoli torrenti sotterranei in quota (ca. 600 metri). Il progressivo
impoverimento quantitativo e qualitativo degli acquiferi di pianura a causa
di uno sfruttamento sempre più intensivo e di un inquinamento sempre
più pesante e diffuso porterà a breve alla necessità di
sfruttare maggiormente le risorse idriche degli acquiferi carsici, predisponendo
il trasporto, anche a distanza, delle risorse idriche montane come già avviene
per molte aree del Sud d'Italia. Fino ad una decina di anni fa, nel nostro
paese, veniva sfruttato non più del 25-30% delle acque provenienti dagli
acquiferi carsici ma in un prossimo futuro si prevede uno sfruttamento pari
al 75-80%.
È
evidente che tali risorse devono essere ben tutelate contro qual-siasi tipo
di inquinamento accidentale o permanente legato alle attività umane
nel territorio.
L'altopiano del Faedo, come ogni altopiano carsico, manca quasi completamente
di idrografia superficiale perché tutta l'acqua di origine meteorica
viene drenata da una diffusa rete di fratture circa parallele e ortogonali
alla "linea di Schio". Nel punto di incrocio delle fratture si
innescano processi di assorbimento e le acque, chimicamente attive, esplicano
un'azione corrosiva radiale che predispone la formazione delle doline. Tale
processo viene esaltato dalla presenza di un manto erboso e forestale che
tende ad arricchire il tenore di anidride carbonica a livello del suolo e,
con il degrado del materiale organico, produce acidi umici che aumentano
di molto il grado di acidità delle acque percolanti. L'azione corrosiva
si esplica su tutta la superficie e in profondità contribuendo all'ampliamento
delle fratture e alla generazione di tubi freatici nei punti di incrocio
tra le diaclasi (fratture aperte) e i giunti di strato (discontinuità tra
uno strato e l'altro).
I tubi freatici di dimensioni maggiori favoriscono la concentrazione dei
reticoli idrici profondi e si ampliano più velocemente a spese di
quelli minori, grazie anche al principio di corrosione per miscela d'acque
a diverso grado di saturazione e al trasporto di elementi abrasivi che sviluppano
una importante azione erosiva. Nel caso della Pissatela, come per il Buso
della Rana, le gallerie principali si sono formate in prossimità del
punto di contatto tra le calcareniti e il basalto, che qui si trova a circa
70-80 metri di profondità rispetto all'ingresso della grotta e lo
scorrimento idrico sotterraneo avviene secondo un sistema a drenaggio dominante
attraverso grossi collettori.
I rami della grotta, a monte dello "Stargate", seguono la pendenza
generale del letto basaltico e quindi hanno un andamento in costante salita
con gradini più o meno marcati legati a diversità litologiche
o a fenomeni di disturbo di natura tettonica. Il dislivello attuale tra lo "Stargate" e
le regioni di "Tira Bora" è di circa ottanta metri, dieci
in più quindi del dislivello tra l'ingresso della grotta e lo "Stargate".
Fra il "Tira Bora" e le fessure che sboccano all'esterno poi ci
sono ancora una cinquantina di metri e ciò spiega perfettamente il
fatto che la grotta, all'ingresso, aspiri aria d'inverno e la soffi d'estate.
Dalla testata della Valle delle Lore, l'asse principale della grotta si sviluppa
verso il roccolo Sella e la cima Faedo, passando sotto un'infinità di
doline che costituiscono come una miriade di imbuti da predisposizione tettonica
i quali raccolgono e veicolano in profondità tutte le acque meteoriche.
In occasione di piogge torrenziali gli ambienti ipogei
sono interessati da piene violentissime che comunque sembra si riducano in
tempi abbastanza brevi. Questo regime dimostra che la comunicazione tra la
superficie e le grandi gallerie sotterranee risulta piuttosto veloce e, di
conseguenza, che la copertura elastico-terrosa ha uno scarso potere di trattenuta.
Ricerche specifiche eseguite da valenti studiosi della materia, hanno stabilito
che l'azione depuratrice di un acquifero carsico, almeno per quanto riguarda
l'inquinamento di origine biologica, è esercitata principalmente dal
suolo e dalla copertura di clastici perché è lì che
avvengono le principali reazioni fisico-chimiche con l'eventuale inquinante.
Superato questo strato, nella roccia sottostante, la circolazione avviene
per lo più in regime vadoso (scorrimento a pelo libero) e quindi con
bassissima se non nulla capacità depurativa. Gli sbancamenti di qualsiasi
tipo in ambiente carsico, per il fatto di ridurre se non eliminare la copertura
elastico-terrosa, facilitano la concentrazione dei reticoli idrici permettendo
l'instaurarsi di una circolazione di tipo a carso scoperto, che risulta la
più vulnerabile per l'acquifero carsico.
Questa situazione, comune alla maggioranza degli altopiani carsici, porta
alla conclusione che la presenza di qualsiasi inquinante che dovesse interessare
l'ambiente superficiale, dalle sostanze organiche ai composti chimici e agli
scarichi industriali, in tempi brevissimi raggiungerebbe le gallerie sotterranee
e di lì la cintura di risorgive che sgorgano all'esterno, nel nostro
caso a livello del contatto calcareniti -basalto, le quali sono oggetto di
captazione idrica da parte della comunità di Monte di Malo.
Considerato il rapido sviluppo futuro delle captazioni idriche degli acquiferi
carsici, sarebbe indispensabile sviluppare tutta una serie di rilevazioni,
secondo metodologie di studio specifiche come la costruzione di mappe di
vulnerabilità; sarebbe importante indagare sul grado di disomogeneità del
massiccio, eseguire analisi continuative sull'eventuale presenza di elementi
inquinanti e registrare l'andamento annuale della loro concentrazione, ecc...
Sarà interessante anche effettuare una rilevazione delle portate medie
annue dei torrenti sotterranei con l'installazione di strumentazione specifica
(idrometrografo) come è stato realizzato dal G.G.S.-C.A.I. nel Buso
del Vento di Monte Magre per conto dell'Amministrazione Comunale di Schio.
Sarà importante ancora raccogliere informazioni sull'andamento delle
piene sotterranee (regime, portate e durata) in relazione al volume delle
precipitazioni, anche per capire il grado di pericolosità delle piene
stesse per gli speleologi impegnati nelle esplorazioni.
Nota bibliografica.
·
Il Buso della Rana (40 V-VI), in «Rassegna Speleologica Italiana»,
anno XIII, 3, pp. 99-164, Albese (CO) 1960.
·
Leonardo BUSELLATO e GRUPPO GROTTE SCHIO C.A.I., Dimensione Buio, Schio 1990.
·
Leonardo BUSELLATO, La "Pissatela" diventa Rana ovvero: metamorfosi
di una grotta, in «Stalattite», XVII, pp. 49-55, Schio 1995.
·
Ugo SAURO, Dinamica geomorfologica e vulnerabilità della risorsa acqua
nell'Altopiano dei Sette Comuni (Prealpi Venete), in «Studi Trentini
di Scienze Naturali» - Acta Geologica, pp.43-51, Trento 1995.
·
Federico LANARO, Faedo by Speleo: trent'anni di esplorazioni sull'altopiano
del Faedo-Casaron, in «Papesatan», pp. 15-39, Malo 1997.
·
Paolo FORTI, Gli acquiferi carsici: problematiche per il loro studio e utilizzo.
Atti del convegno nazionale sull'inquinamento delle grotte e degli acquiferi
carsici e possibili ricadute sulla collettività, pp.13-40, Gruppo Speleologico
Padovano C.A.I., Padova 1999.
·
Paolo MIETTO e Ugo SAURO, Grotte del Veneto (2), Verona 2000.
·
Bartolomeo VIGNA e Gilberto CALANDRI, Gli acquiferi carsici, Quaderni didattici
SSI-CAI, Genova 2001.
·
Papanero: altro buco soffiante del Faedo-Casaron, in «Papesatan»,
pp.19-21, Malo 2002. Acqua e acque della Valleogra, «Sentieri Culturali»,
2, Schio 2002.
·
Enrico GLERIA, Atlante delle cavità naturali dell'altopiano Faedo-Casaron
(in corso di stampa).